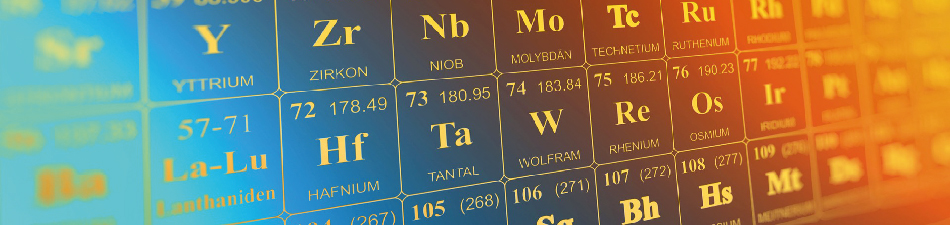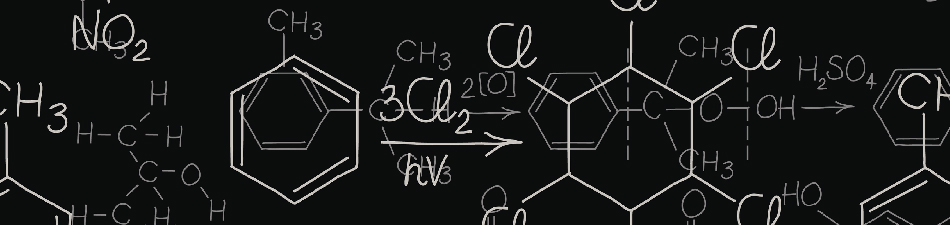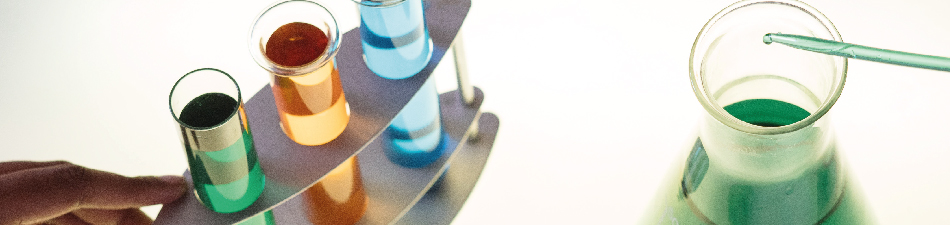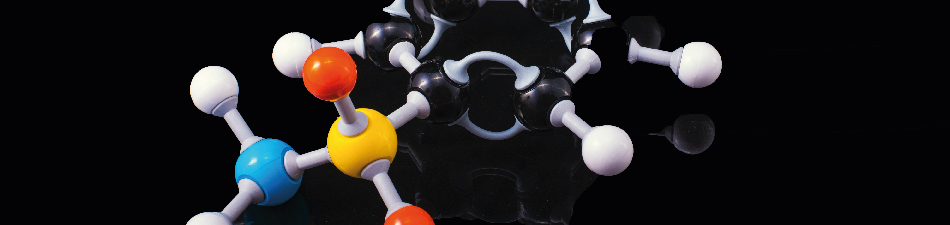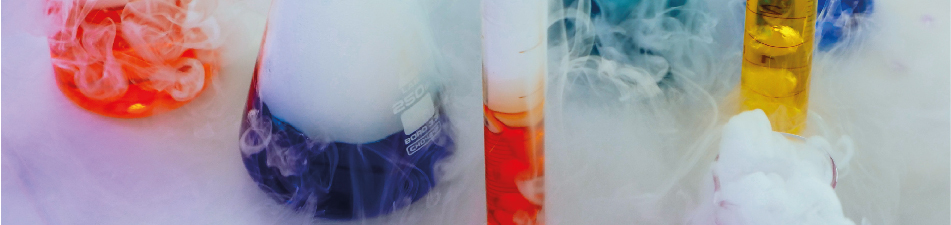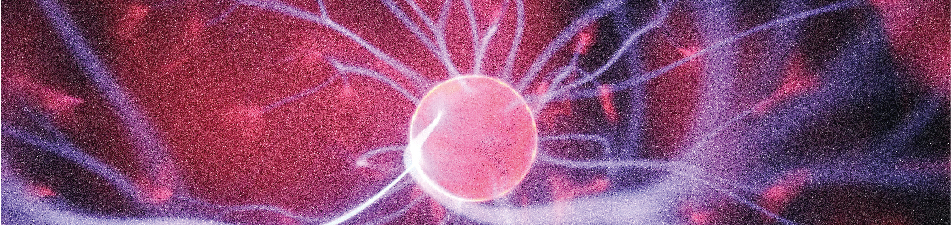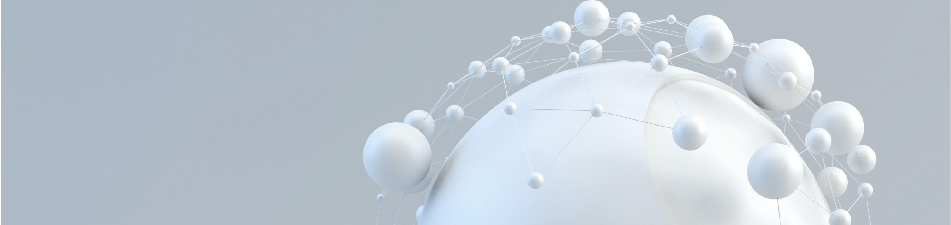Feed aggregator
Acido trifluoro acetico la nuova sfida
Mauro Icardi
L’acido trifluoroacetico (TFA), composto organico fluorurato di formula CF₃COOH, è l’acido a catena più corta appartenente al gruppo dei composti denominati PFAS.
Dal punto di vista della produzione industriale si tratta di un fine chemical, ovvero viene prodotto in piccole quantità ad alto valore aggiunto. Ed è per questa ragione che i ricercatori stanno cercando di capire il perchè venga rinvenuto sempre più spesso nell’ambiente, e la sua concentrazione stia aumentando considerevolmente. Non solamente nelle acque superficiali ma anche nelle reflue e in quelle imbottigliate.
Secondo recenti ricerche, l’aumento dei TFA nell’acqua piovana coincide con la sostituzione di vecchi gas refrigeranti (come i CFC, vietati dal Protocollo di Montreal del 1989) con altre sostanze apparentemente meno dannose per lo strato di ozono. Tuttavia, questi nuovi composti finiscono per trasformarsi in precursori del TFA, perpetuando così il problema di un inquinante che non intacca lo strato di ozono, ma è resistente alla biodegradazione. I principali precursori della molecola provengono anche dai pesticidi, le schiume antincendio, i farmaci.

La diffusione del TFA non è limitata solo al ciclo idrologico visto che è stato trovato nel vino, nella birra e persino nel sangue umano.In un recente studio condotto dall’European Pesticide Action Network, il TFA è stati riscontrato nei vini di almeno dieci paesi europei, tra cui la Spagna, con una concentrazione media di 110 microgrammi per litro. Inoltre, analisi di colture e vegetazione forestale hanno dimostrato la capacità dei TFA di concentrarsi nelle foglie delle piante, senza subire processi di biodegradazione ambientale.
In questo scenario, la gestione dei TFA e la tutela dell’ambiente e della salute umana diventano sfide che richiedono una risposta coordinata e a lungo termine. Il monitoraggio e la ricerca continui sono essenziali per comprenderne meglio il comportamento e progettare strategie e tecniche efficaci per ridurne l’impatto.
Attualmente, l’acido trifluoroacetico non è regolamentato come sostanza pericolosa dalla normativa europea REACH o dalla Direttiva UE sulle Acque, ma è incluso tra i composti di interesse a causa del suo potenziale impatto ecotossicologico (D.Lgs. 102/2025 introduce un limite specifico per il TFA nell’acqua potabile a 10 µg/L (microgrammi per litro), che diventerà obbligatorio dal 12 gennaio 2027).
Dal punto di vista del trattamento delle acque, l’unica tecnica che si è dimostrata efficace nel rimuovere la molecola del TFA è quella dell’osmosi inversa. Tecnica però che per ragioni di consumo energetico e di complessità di applicazione specialmente sulle acque reflue, non può di fatto essere utilizzata se non modificando profondamente gli impianti di trattamento che hanno portate elevate.
La nuova sfida è capire come gestire una molecola non degradabile naturalmente, molto solubile e con diffusione ubiquitaria. Il problema ovviamente riguarda non solo il comparto tecnico scientifico. Certamente coinvolge le associazioni ambientaliste. Poi i cittadini, ma in questo caso intravedo il rischio ormai acclarato del complottismo che si lega a filo doppio al negazionismo. Purtroppo la salute dell’ambiente è diventato un tema marginale nelle agende politiche. Ma sarebbe giusto ricordare che, per questo e per altri problemi il tempo non è dalla nostra parte. E non è saggio sprecarne altro.
Link di approfondimento
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.4c06189
H2-driven biocatalytic O-demethylation of lignin derived aromatics in a closed-loop flow system powered by water electrolysis
DOI: 10.1039/D5GC05054E, Paper
 Open Access
Open Access    This article is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported Licence.Donato Calabrese, Guiyeoul Lim, Parsa Nayyara, Megan E. Wolf, Paul R. F. Cordero, Lindsay D. Eltis, Lars Lauterbach
  This article is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported Licence.Donato Calabrese, Guiyeoul Lim, Parsa Nayyara, Megan E. Wolf, Paul R. F. Cordero, Lindsay D. Eltis, Lars LauterbachWe demonstrate an H2-driven, closed-loop biocatalytic system integrating water electrolysis with efficient O-demethylation of lignin aromatics for sustainable chemical production.
To cite this article before page numbers are assigned, use the DOI form of citation above.
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
Photocatalytic modular synthesis of functionalized cyclotetrasiloxane (D4) monomers toward tailored polysiloxanes
DOI: 10.1039/D5GC05780A, CommunicationShaowei Chen, Zhiqiang Fang, Xiaoqian He, Qi Jia, Yanchuan Zhao, Xiao Shen
We report a photocatalytic radical C–H functionalization strategy for modular modification of octamethylcyclotetrasiloxane, accommodating diverse functional groups to efficiently access functionalized polysiloxanes.
To cite this article before page numbers are assigned, use the DOI form of citation above.
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
Unexpected magnesium oxide/calcium sulfide barnacle-like structures derived from pyrolysed carrageenans
DOI: 10.1039/D5GC03892H, Paper
 Open Access
Open Access    This article is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported Licence.Ewan D. Ward, Jolyon J. Glynn, Ryan E. Barker, Duncan J. Macquarrie, Avtar S. Matharu
  This article is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported Licence.Ewan D. Ward, Jolyon J. Glynn, Ryan E. Barker, Duncan J. Macquarrie, Avtar S. MatharuDerived from a metal–organic framework of Irish Moss carrageenan and naturally inherent magnesium and calcium, this barnacle-impersonating material, offers a potential solution to aquatic heavy metal pollution and critical metal recovery.
To cite this article before page numbers are assigned, use the DOI form of citation above.
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
Sustainable bubble-mediated dynamic triphasic antisolvent crystallization for magnesium sulfate nano–micro particles: precise size and morphology control
DOI: 10.1039/D5GC05730B, PaperYingchen Wang, Sheng Liu, Jiaqi Luo, Mingting Yuan, Yimin Jia, Qiutong Zhang, Wenhao Yan, Qiushuo Yu
Sustainable bubble-mediated dynamic triphasic antisolvent crystallization was proposed and applied in the production of nano–micro particles.
To cite this article before page numbers are assigned, use the DOI form of citation above.
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
Strategic sodium modulation for low-temperature fabrication of phase-pure Na3V2(PO4)3 cathodes: mechanistic insights and performance optimization in sodium-ion batteries
DOI: 10.1039/D5GC05076F, PaperZhaojin Li, Yunbo Di, Zhicheng Wang, Di Zhang, Huilan Sun, Qujiang Sun, Qiujun Wang, Fei Yuan, Ranran Li, Bo Wang
The influence mechanism of Na content on NV2P crystal growth has been clearly revealed.
To cite this article before page numbers are assigned, use the DOI form of citation above.
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
Low-temperature synthesis of red carbon dots with precise spectral conversion via a microwave–solvothermal method and application in spectral conversion films
DOI: 10.1039/D5GC05645D, PaperYing Wang, Jiayu Liu, Xinyan Fan, Yonggui Wang, Zefang Xiao, Yanjun Xie
This study developed a microwave–solvothermal method for the rapid synthesis of solid-state luminescent carbon dots (CDs) at a low temperature of 60 °C–100 °C and their application in spectral conversion films.
To cite this article before page numbers are assigned, use the DOI form of citation above.
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
Sintering- and coking-resistant Ni/HTASAO5 catalysts for high temperature dry reforming of methane
DOI: 10.1039/D5GC05472A, PaperJiashi Zhu, Xueshuang Wu, Haiqing Cai, Li Li, Jing Yang, Hanyi Liu, Jianli Wang, Guiying Li, Changwei Hu
Dry reforming of methane (DRM) provides a promising strategy for combating global warming by concurrently converting two greenhouse gases, CH4 and CO2, to value-added syngas. The Ni/HTASAO5 catalyst exhibited high activity and stability at 900–1000 °C.
To cite this article before page numbers are assigned, use the DOI form of citation above.
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
A review of preparation processes for SiO2 aerogel insulation materials: green pathways for silicon extraction, drying, and modification
DOI: 10.1039/D5GC04891E, Tutorial ReviewYujia Bai, Yina Qiao, Haoxiang Zhang, Riya Jin, Mengye Jia, Jiaoqin Liu, Zengdi He, Jiawei Nie
Optional green pathways for silica aerogel preparation from agricultural waste, including silicon extraction, drying, and modification.
To cite this article before page numbers are assigned, use the DOI form of citation above.
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
Dual-site synergy boosting CO2 reduction to multi-carbon products on copper-conjugated electrocatalysts
DOI: 10.1039/D5GC04944J, PaperJianxia Gu, Haiping Zhou, Fanfei Meng, Chunjing Tao, Guogang Shan, Jingting He, Zhongmin Su, Chunyi Sun
A conjugated copper–porphyrin framework with synergistic dual catalytic centers is developed, where the Cu3L3 cluster drives C–C coupling while the porphyrin center acts as an additional active site and modulates electronic properties.
To cite this article before page numbers are assigned, use the DOI form of citation above.
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
Biocompatible ultrafast thiol-acetalization enabled by triaryl carbenium ion-pair
DOI: 10.1039/D5GC03823E, PaperPeng Chen, Ming Zou, Yu Zhang, Niuniu Li, Ruoqi Li, Lijuan Liang, Zhenguo Zhang, Teck-Peng Loh, Zhenhua Jia
A highly efficient, metal-free protocol has been developed for the ultrafast thiol-acetalization of aldehydes and ketones with thiols in water, catalyzed by a triaryl carbenium ion-pair under biocompatible conditions.
To cite this article before page numbers are assigned, use the DOI form of citation above.
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
A switchable reductive cyclization of o-alkyl nitroarenes: divergent synthesis of heterocycles
DOI: 10.1039/D5GC05521K, PaperMeiqi Zhu, Hangyu Zhou, You Su, Zheng-Jun Wang, Yikun Chen, Xinyu Xu, Dingyi Wang
This metal-free protocol enables the rapid and highly selective conversion of ortho-alkyl nitroaromatics into diverse heterocycles—including thiophenes, quinolines, and N-hydroxyindoles—in moderate to good yields.
To cite this article before page numbers are assigned, use the DOI form of citation above.
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
Unlocking overall electrolysis efficiency: pairing value-added reduction reactions with oxidative valorization of biomass-derived compounds
DOI: 10.1039/D5GC04516A, Critical ReviewYan Zhong, Feng Liu, Chengyu Fang, Qi Huang, Xubo Huang, Chunxian Guo
A paired electrolysis system for integrating biomass oxidation reactions with high-value reductive reactions enables valuable products co-generation and overall efficiency improvement.
To cite this article before page numbers are assigned, use the DOI form of citation above.
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
A green one-pot strategy for sustainable fully lignin-based adhesives
DOI: 10.1039/D5GC05305F, PaperCheng Zuo, Xin-Yi Hui, Pin-An Xin, Hao-Nan Qi, Zhuo-Hua Sun, Jia-Long Wen, Tong-Qi Yuan
A one-pot strategy enables the simultaneous depolymerization, demethoxylation, and hydroxymethylation of industrial lignin to prepare sustainable fully lignin-based adhesives.
To cite this article before page numbers are assigned, use the DOI form of citation above.
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
Visible-light-induced chemoselective dicarboxylation of alkynes using formate and CO2
DOI: 10.1039/D5GC05126F, PaperJiayuan Li, Daoshun Chen, Chanjuan Xi
Visible-light-induced dicarboxylation of alkynes with CO2 and formate for the synthesis of succinic acids has been developed under mild conditions. Mechanistic experiments proved that the formate enabled the reaction to proceed via CO2•−
To cite this article before page numbers are assigned, use the DOI form of citation above.
The content of this RSS Feed (c) The Royal Society of Chemistry
Quale altra vita nel sistema solare?
Diego Tesauro
La pluralità dei mondi abitati dalla vita è un tema oggetto del dibattito filosofico che data dai tempi di Talete (circa 600 a.C.) ed è continuata nel tempo, in forme molteplici, attraverso il pensiero greco, quello cristiano, per giungere all’Illuminismo fino all’epoca contemporanea, assumendo contorni largamente influenzati dalle idee scientifiche. Tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento il dibattito, strettamente filosofico, con l’avanzare della conoscenza, grazie ai progressi della scienza, si è spostato verso speculazioni sulla vita extraterrestre focalizzando su corpi particolari ed osservazioni sui principi cardini alla base della vita. Uno di questi principi, oltre la presenza degli elementi chimici essenziali, tra cui carbonio, idrogeno, azoto, ossigeno, fosforo e zolfo (CHNOPS), e dell’acqua in fase liquida, è la disponibilità di energia chimica per innescare reazioni di ossido riduzioni che rendano disponibili il carbonio in bassi stati di ossidazione e l’azoto nello stato di ossidazione -3. La disposizione di elettroni nella maggior parte dei casi sulla Terra è fornita dalla reazione di ossidazione dell’ossigeno dell’acqua ad opera della fotosintesi, anche se alcune forme estremofile utilizzano lo zolfo del solfuro di idrogeno (H2S). Se ci concentriamo sulla presenza dell’acqua è necessario prevedere dei meccanismi di ossidazione dell’ossigeno e riduzione dell’idrogeno. E’ da queste premesse che la possibilità di trovare delle forme di vita si è ristretta a qualche satellite dei pianeti giganti Giove e Saturno.
In particolare Europa, uno dei 4 satelliti scoperti da Galileo Galilei, quando per la prima volta diresse il suo cannocchiale verso Giove, la notte dell’ 11 gennaio 1610, è stato eletto come sede possibile di forme di vita microbica. Le osservazioni raccolte per mezzo della sonda spaziale, che prese il nome del grande astronomo fiorentino, (https://it.wikipedia.org/wiki/Sonda_Galileo), dimostrarono che, sotto una crosta di ghiaccio, era presente un oceano di acqua liquida.
Figura 1: Il satellite Europa ripreso dalla sonda Juno. Si notano le striature sulla superficie ghiacciata

Al recente congresso annuale dell’AGU (American Geophysical Unions) tenutosi in questo mese di dicembre 2025 sono stati considerati meccanismi alternativi per sostenere le fonti di energia chimica [2]. Un meccanismo innovativo basato sul decadimento degli isotopi radioattivi (con tempi di dimezzamento lunghi quali ad esempio, ⁴⁰K, ²³⁵U, ²³⁸U) guida la radiolisi dell’acqua liquida, generando locali disequilibri chimici. I nuovi modelli mostrano che anche a basse concentrazioni di questi isotopi si possono produrre specie sia ossidanti che riducenti significative negli ambienti acquosi senza un’interazione attiva tra acqua e rocce. A seconda della salinità, questi gradienti redox potrebbero sostenere circa 1.000 cellule microbiche per litro a salinità comparabili a quelle del mare terrestre. Questi valori rientrano nell’intervallo delle stime precedenti per l’oceano di Europa (~100-100.000 cellule per litro) e la biomassa equivalente sarebbe di circa 10²³ – 10²⁶ cellule, confrontabile con la biomassa di circa 1.000-1.000.000 di balene azzurre.
Si stimò che l’oceano sotterraneo potesse essere profondo tra i 60 e i 150 chilometri, contenendo più del doppio del volume di tutti gli oceani della Terra. Inoltre la presenza degli elementi fondamentali era garantita dal bombardamento di meteoriti presenti in tutti i satelliti gioviani.
L’altra condizione cioè la produzione di idrogeno ed ossigeno richiedeva che si trovasse un meccanismo. Essendo l’oceano a contatto diretto con un fondale roccioso, uno scenario prevedeva che le reazioni chimiche fossero prodotte attraverso disequilibri chimici dall’interazione continua acqua-roccia. In questo modo modelli geochimici, analoghi a quelli terrestri, dovrebbero generare grandi e persistenti flussi di ossigeno e idrogeno di Europa, approssimativamente 10¹¹ e 1010 mol all’anno rispettivamente. Questi flussi potrebbero bilanciarsi in un modo unico tra i mondi ghiacciati potenzialmente abitabili del sistema solare. Recentemente è stato sollevato qualche dubbio sul fatto che tali interazioni siano attualmente attive su Europa. Alternativamente, ma anche cooperativamente, i flussi di idrogeno ed ossigeno e nutrienti per la vita potrebbero provenire dall’interazione della radiazione solare sulla superficie del ghiaccio.
L’involucro di ghiaccio isolante, stimato tra i 15 e i 25 chilometri di spessore, proteggerebbe l’oceano dal vuoto dello spazio e dalle radiazioni intense. È proprio la stima dello spessore del ghiaccio che in questa fase sembra essere dirimente per la presenza della vita.
Gli studi su Giove e suoi satelliti sono proseguiti con la sonda Juno, la quale, il 29 settembre 2022, volando a 360 chilometri da Europa, scansionò il fondo con il suo radiometro a microonde, offrendo le prime misurazioni dirette del ghiaccio. Questo strumento ha misurato il calore emesso dalla crosta ghiacciata di Europa riuscendo a misurare la temperatura a varie profondità. È stato inoltre in grado di rilevare variazioni di temperatura dovute a imperfezioni nella lastra di ghiaccio. Fu stimato che lo spessore più probabile della lastra di ghiaccio fosse di circa 29 chilometri, più spesso della maggior parte delle stime precedenti, ma potrebbe essere spesso anche solo 19 chilometri oppure arrivare fino a 39 chilometri.
In modo cruciale, le crepe, i pori e altre imperfezioni probabilmente si estendono solo a profondità di alcune centinaia di metri nel ghiaccio, e i pori hanno un raggio di solo pochi centimetri cioè non sono abbastanza profonde e non sono abbastanza grandi. Ma perché queste misure sono cruciali?
Innanzitutto bisogna ricordare che Europa è lontana dal Sole mediamente circa 1 miliardo di chilometri per cui l’intensità della radiazione solare UV è molto debole. Ora uno spessore dello strato di ghiaccio, se protegge forme di vita dai raggi cosmici, limita anche la possibilità che avvengano reazioni di decomposizione dell’acqua producendo idrogeno ed ossigeno elementare, fornendo un potenziale meccanismo di ossigenazione per l’oceano sotterraneo di Europa e di produzione di agenti riducenti.
Inoltre un afflusso di nutrienti nell’oceano sarebbe molto ridotto. La presenza di fenomeni di dissociazione della superficie di ghiaccio d’acqua di Europa nei suoi elementi è stata dimostrata e riportata lo scorso anno da uno studio pubblicato su Nature Astronomy [1] con osservazioni dirette di ioni H2+ e O2+ che confermano che queste specie sono tra i principali costituenti atmosferici. Ma i dati quantitativi sulla loro produzione sono inferiori a quanto si pensasse in precedenza, con un intervallo più ristretto a supporto della abitabilità nell’oceano di Europa. Pertanto sembravano ridursi le possibilità di forme di vita su Europa. A questo punto tutti gli indizi erano favorevoli ad un accantonamento dell’ipotesi di possibilità di vita su Europa, ma più recentemente una nuova ipotesi si è affacciata.
La missione Europa Clipper della NASA (https://science.nasa.gov/mission/europa-clipper/) (Figura 2), lanciata nel 2024, potrebbe essere in grado di rilevare la degradazione di alcuni di questi elementi quando arriverà in orbita attorno ad Europa il prossimo decennio per una serie di sorvoli a bassa quota sul ghiaccio. In particolare mediante la strumento Mass Spectrometer for Planetary EXploration/Europa (MASPEX) potrà rilevare la produzione di ⁴⁰Ar generata dal decadimento del ⁴⁰K. Quindi per poter rispondere alla domanda che ci siamo posti all’inizio dovremo aspettare la missione Europa Clipper nel 2031, anche se come spesso accade, sarà probabile che a fronte di nuovi dati, i risultati di questa missione ci daranno nuovi interrogativi come spesso avviene nel campo scientifico.

Figura 2: Europa Clipper è una missione spaziale interplanetaria della NASA per l’esplorazione di Europa, satellite di Giove. La sonda studierà Europa tramite una serie di sorvoli durante la sua orbita intorno a Giove. Nella seconda immagine il lancio effettuato da cape Canaveral il 14 ottobre 2024 con il vettore con il Falcon Heavydi SpaceX.
Riferimenti:
[1] J.R. Szalay et al. Nature Astronomy 2024,8,567–576. https://doi.org/10.1038/s41550-024-02206-x
[2] Truong et al. https://agu.confex.com/agu/agu25/meetingapp.cgi/Paper/1933809
I vermi dello sport.
Claudio Della Volpe
Come forse ricorderete ho inventato anni fa un anagramma per “giornalista”, che spesso è adatto (per fortuna non sempre): ignoralista.
Beh in questo caso che vi racconto oggi è adeguato, ci consente di stare in guardia sulle cose.
Dunque il 22 dicembre us escono una serie di articoli su vari giornali e siti web dedicati ad una “nuova” procedura di doping nello sport e specie nel ciclismo. Tutti parlano di una “nuova frontiera” del doping e di risultati fuori di testa.

Qua addirittura il Corriere pone che la cosa sia venuta dai “laboratori di Bielorussia e Cina”, i cattivi dell’occidente, e per forza, chi volete che inventi cose così “cattive” se non i cattivi di turno? Il Corriere, schieratissimo per la guerra, fa peggio de Il Giornale, che perlomeno non inventa nulla.

Anche un sito dedicato allo sport riprende questa news così “importante” sempre con toni sopra le righe.
A questo punto ho cercato di informarmi meglio e mi sono messo a cercare su web ed ho trovato varie cose.
Anzitutto la notizia è vecchia di almeno due anni (in realtà molto di più come vedremo) come si vede dai titoli che riporto qua, il primo è di Repubblica (occhio alle date):


Qua almeno si rinuncia ai cattivi e si pone come scopritore una startup francese.
Dunque roba di almeno due anni fa, ma in realtà era conosciuta almeno 6 anni fa. Tutto meno che una novità, insomma.
Di cosa si tratta? Le informazioni riprese da siti scientifici o pubblicazioni sono affidabili? Ed è vero che sia impossibile o difficile da rivelare? Quando è stata scoperta?

Anzitutto ecco il verme di cui si parla, Arenicola Marina, un anellide comunissimo sulle nostre spiagge. Sicuramente lo avrete notato o avrete notato i segni della sua presenza, come i buchi circolari nella sabbia o le formelle di sabbia espulse dopo averle ”digerite”. L’arenicola è un vero ingegnere edile del fondale marino. La sua dimora tipica è una tana a forma di U, che il verme costruisce con meticolosa precisione. La tana è composta da due gallerie: un tunnel a forma di L rivestito di muco, che rappresenta la parte abitativa del verme, e un fusto verticale non rivestito che emerge dalla superficie della sabbia. Questo fusto, chiamato albero della testa, serve come punto di ingresso per l’acqua di mare e per l’espulsione dei sedimenti. L’arenicola si nutre per filtrazione. Ingerisce grandi quantità di sabbia, trattenendo le particelle organiche nutritive e espellendo i sedimenti inorganici attraverso l’albero della coda. Questo processo di filtrazione contribuisce a riciclare i nutrienti nel fondale marino e a ossigenare la sabbia, creando un ambiente favorevole per la proliferazione di altri organismi.
Da https://fishpro.it/arenicola-marina/pesca-sportiva/
Gli studi sulla fisiologia degli anellidi risalgono almeno al 1970, e le caratteristiche della “eritrocruorina” di verme furono studiate a partire dal 1933 (in Europa); in realtà da quasi 30 anni si sa che la emoglobina di questo verme ha proprietà estremamente interessanti tanto da aver dato luogo ad una bella serie di articoli che ne hanno studiato struttura e proprietà (alcuni lavori sono elencati in fondo), il primo del 1997! Tutto il lavoro è stato svolto in laboratori universitari e di ricerca europei ed americani. La Cina e la Bielorussia? Bah. L’autore del lavoro del 1997 (francese) scrive nel 2021
È stato dimostrato che l’Hb di Arenicola marina (indicata col nome di M101, e commercializzata come HEMO2life® da Hemarina (Morlaix, Francia) (grassetto mio) è in grado di trasportare efficacemente l’O2 in vivo senza alcun segno di ossidazione, vasocostrizione o ipertensione (problemi che si riscontrano con altre molecole). Le grandi tasche eme dell’Hb dell’Arenicola marina consentono all’O2 di fuoriuscire facilmente in modo passivo. È degno di nota il fatto che l’Hb dell’Arenicola marina abbia un’affinità con l’O2 significativamente più elevata, come dimostra il suo valore p50 più basso (7,05 ± 0,93 mmHg) rispetto a quello del sangue umano, mirando la sua azione di trasporto dell’O2 a un ambiente più ipossico. Tuttavia, il p50 dell’M101 è strettamente correlato al p50 dell’HbA umana all’interno dei globuli rossi e anche la sua cooperatività è simile.https://doi.org/ 10.3390/md19070376
(Nota: La P50 dell’emoglobina è la pressione parziale di ossigeno (PO2), espressa in millimetri di mercurio (mmHg), alla quale il 50% delle molecole di emoglobina è saturato di ossigeno; è un indicatore chiave dell’affinità dell’emoglobina per l’ossigeno, che riflette la sua capacità di legare e rilasciare O2 nei tessuti, con un valore normale intorno a 27 mmHg. Un valore di P50 più basso indica maggiore affinità, mentre un valore più alto indica minore affinità (rilascerà più facilmente)).
Dunque la proteina M101 è commercializzata in Francia da una ditta francese già 5 anni fa almeno, con scopi prettamente medici: perfusione di tessuti da trapiantare o altre applicazioni terapeutiche. Ma come vedremo si sa benissimo che si potrebbe usare diversamente.

Le caratteristiche chimiche della emoglobina dell’arenicola sono stupefacenti.La molecola è un complesso di 12 sub-unità esagonali disposte in due strati sovrapposti (struttura hexagonal bilayer). Molto più grande della nostra emoglobina, che ha una struttura quaternaria con 4 subunità, (studiata da Monod se ricordate) questa ne ha 12 in ogni strato. Pesa 3600 KDa contro i 64.5 (o 68 includendo il ferro) del tetramero umano e trasporta 156 molecole contro le 4 di quella umana.

Le sue caratteristiche sono eccezionali; il verme deve aver grande facilità di assorbimento ossigeno potendo respirare per periodi brevissimi. La struttura a raggi X dell’emoglobina del verme “costruttore di tubi” (Lugworm) Arenicola marina è stata risolta (in bassa risoluzione, vedi in fondo), rivelando una molecola extracellulare cava a forma di sfera, composta da 24 subunità globulari organizzate in un dimero di dodecamero, che presenta un meccanismo unico per il trasporto di ossigeno, fondamentale per la sua vita in ambienti ipossici. A differenza delle emoglobine dei vertebrati, quella dell’Arenicola marina si trova nel sangue (emolinfa) e non all’interno dei globuli rossi, e mostra una curva di dissociazione dell’ossigeno sigmoidea e indipendente dal pH (come è la nostra invece).
Il ferro nell’eme di Arenicola marina ha la stessa coordinazione fondamentale che nell’emoglobina umana, ovvero esa-coordinazione, con quattro siti legati agli azoti dell’anello porfirinico, uno all’istidina (His F8) e l’ultimo reversibilmente all’ossigeno (o monossido di carbonio). La differenza è nel contesto proteico: l’eme umano è in un ambiente più complesso (struttura quaternaria con subunità) rispetto all’eme di Arenicola, che ha un’unica catena proteica (mioglobina-simile) ma con una coordinazione e capacità di legare O2 simile, anche se con adattamenti funzionali all’ambiente in cui vive.
Queste caratteristiche sono utilissime per irrorare tessuti di altre specie, anche umani, una tecnica che ha applicazioni oneste e disoneste; la parola EPO è diventata tragicamente nota nel modo sportivo da molto più che vent’anni. Ricordate il caso del Tour?

Che questo sistema di doping non capisse le possibilità aperte da una emoglobina che non ha effetti collaterali a differenza di tutte quelle usate finora era impossibile; tanto è vero che chi lotta contro il doping ci ha pensato subito; e non 2 anni fa come avevo letto in un primo momento (guardate qua sotto), ma quasi 10 anni fa!!!!
Nel 2016 una rivista scientifica dedicata riportava la possibilità e la tecnica per rivelarla e ne mostrava anche tutti i limiti e le opzioni; leggete sotto; traduco per chi non volesse farlo o non sapesse l’inglese:
La manipolazione del sangue e dei suoi componenti è vietata nello sport dall’Agenzia mondiale antidoping (WADA). Ciò include l’uso di sostituti del sangue per aumentare il trasporto di ossigeno, come i trasportatori di ossigeno a base di emoglobina (HBOC), che sono composti derivati dall’emoglobina. Nonostante il loro interesse medico, la prima generazione di HBOC aveva gravi effetti collaterali ed è stata abbandonata. Tuttavia, nuovi studi stanno ora sfruttando le proprietà delle emoglobine dei vermi marini, che circolano come complessi extracellulari giganti con elevate capacità di legame dell’ossigeno. HEMOXYCarrier® (HC), sviluppato da Hemarina, è uno degli HBOC più avanzati e promettenti, e HC potrebbe diventare uno strumento di doping allettante per gli atleti in futuro. (grassetto mio)In questo caso, il rilevamento di HC nel plasma/siero è stato valutato con il metodo utilizzato per rilevare i primi HBOC, basato sull’elettroforesi e sulle proprietà dell’eme perossidasi. Un prodotto derivato dall’HC è stato identificato nel plasma umano fino a 72 ore dopo l’incubazione in vitro a 37 °C. La degradazione dell’HC ha anche indotto la formazione di metemoglobina. Dopo aver iniettato HC alla dose efficace di 200 mg/kg nei topi, il prodotto derivato dall’HC è stato rilevato solo per poche ore e non è stato osservato alcun accumulo di metemoglobina. A causa di questa finestra di rilevamento limitata in vivo, la misurazione dei prodotti specifici di degradazione della globina mediante spettrometria di massa potrebbe essere un’alternativa per future analisi antidoping.

Il lavoro del 2023 estende la finestra di riconoscimento ad otto ore invece di tre.

In conclusione, le procedure di doping di cui si dice che sono recentissime, impossibili da rivelare e inventate in Bielorussia e Cina sono invece conosciute da almeno 10 anni e sono effettuate mediante l’uso di prodotti studiati e commercializzati in Europa da ditte europee per applicazioni mediche; i metodi di rivelazione esistono almeno dal 2016 e sono efficaci per un certo tempo, al momento 8 ore. Le applicazioni di queste tecniche sono state fatte in Europa, al Tour, sia pure in forme diverse già da oltre 20 anni e le hanno fatte corridori americani ed europei.
Ma dove stanno i bielorussi e i cinesi? Il Corriere sostiene di avere le prove che gli esperimenti erano stati fatti in Bielorussia e Cina ma non le ha mica rivelate; beh forse non ce n’è bisogno, sono cose che si sapevano già e da prima, come vi ho mostrato. Questa cosa mi fa pensare alla famosa fialetta di Colin Powell. Ve la ricordate? Una palla per giustificare l’invasione del cattivo Iraq.
Insomma veramente una debacle della stampa italiana filobellicista, che pur di trovare cattivi non “occidentali” si inventa di tutto. Che pena!
Consultati:
· Bailly, X., et al. (2021). “Therapeutic Potential of Hemoglobin Derived from the Marine Worm Arenicola marina.” Marine Drugs. Questo analizza sia la struttura chimica che le applicazioni cliniche (nome commerciale M101).
· Barrou, B., et al. (2025). “A New Oxygen Carrier for Therapeutic Applications.” Drug Testing and Analysis. Articolo aggiornato al gennaio 2025 che discute gli sviluppi correnti e futuri di questa molecola in ambito medico.
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/emoglobina-mioglobina.html
Struttura a bassa risoluzione (Raggi X):
Strange, R. W., et al. (2007). “Low Resolution Crystal Structure of Arenicola Erythrocruorin.” Biophysical Journal, 92(6), 2127–2133. PMID: 17208920 — Questo studio fornisce dettagli sulla disposizione dei “linker” e delle catene globiniche.
Ricostruzione 3D (Crio-EM):
Lamy, J. N., et al. (2001). “Occurrence of Two Architectural Types of Hexagonal Bilayer Marine Worm Hemoglobins.” Journal of Structural Biology, 133(1), 32-42. PMID: 11162090 — Definisce il modello a esagono bilaminare per l’arenaicola.
Caratterizzazione della molecola M101 e di altre
Zal, F., et al. (1997). “Quaternary structure of the extracellular haemoglobin of the lugworm Arenicola marina.” European Journal of Biochemistry, 243(1-2), 85-92. PMID: 9030725 — Studio fondamentale sulla massa e la composizione delle 198 catene.
Numoto, N., et al. (2005). “Crystal structure of the giant hemoglobin from the gutless beard worm Lamellibrachia satsuma.” Proceedings of the Japan Academy, Series B, 81(8), 296-301. DOI: 10.2183/pjab.81.296
Italiani e musei.
Luigi Campanella, già Presidente SCI
Gli italiani ed i Musei sono in un rapporto virtuoso nell’interesse degli uni e degli altri: crescono i visitatori, crescono i fondi a disposizione, si impreziosiscono i Musei. La storia museologica del nostro Paese è fra le più complesse che si possano ipotizzare: privati e pubblico coinvolti, modello disciplinare e modello tematico alternativamente prevalenti, camera delle meraviglie e rappresentazione razionale della realtà, in vitro ed in vivo, teorici e sperimentali.
La realtà di oggi e stata illustrata dal Rapporto 1996-2023 Libro Bianco dei Musei Italiani, in occasione dell’ottava edizione del RO.ME – Museum Exhibition, un evento che ha fatto incontrare gli stakeholder della filiera museologica provenienti dalle istituzioni culturali, politiche, sociali.

I dati trasmessi parlano di una presenza di visitatori in aumento di circa il 6%, negli ultimi 3 anni per un totale di 60 milioni di visitatori con Uffizi, Colosseo e Pompei al top delle presenze.
Better Together” è il tema centrale dell’edizione 2025 di RO.ME – Museum Exhibition, che si è sviluppata come una fiera internazionale dedicata ai musei e ai luoghi della cultura, che si è tenuta (ovviamente a Roma) a novembre 2025, focalizzandosi sia sulla collaborazione, il fundraising e il futuro dei musei nell’era digitale e sociale, ma anche ad una crescita della inclusione, dell’accessibilità, del partenariato pubblico-privato.
Un tema molto importante dell’evento ha riguardato le periferie: i Musei generalmente sono situati al centro della città con eventi preclusi a chi, vivendo nelle periferie, occupa una parte del tempo libero residuo proprio negli spostamenti casa/lavoro. Bisogna allora contrastare questa sensazione di abbandono con iniziative decentrate che portino la cultura anche ai confini delle città. Privare i cittadini meno fortunati di un tempo di contemplazione e riflessione, quale quello vissuto nei Musei, significa privarli di strumenti di resistenza alla violenza ed al caos rumoroso del mondo.
A proposito di beni culturali esposti nei Musei e del loro valore l’ultima rilevazione indica in grande crescita di valore, per esempio per i mappamondi (da 250mila a 750mila euro). Vale lo stato di conservazione, l’assenza di errori, la provenienza geografica e museale. Sono divenuti sempre più rari nel mercato in quanto le Sovraintendenze li hanno progressivamente sottratti alla logica del mercato. Così oggi sono in netta controtendenza con l’antiquariato che vive un momento di fatica.
Un altro settore in crescita di valore è quello dei tesori d’Oriente, in particolare le spade samurai e le armature giapponesi, una katana è stata battuta per 1,5 milioni di euro. Sembra quasi che come la ricerca, anche la cultura a volte guardi più alla tradizione che all’innovazione, peraltro in molti casi facilitando la scoperta di falsi e contraffazioni
All’interno di questo rapporto Cittadini/Musei i Musei Scientifici sono sostanzialmente indirizzati a una categoria di visitatori stimolati o guidati da scuole ed università. Tuttavia nonostante la predominanza di musei d’arte e archeologici nelle classifiche generali, i musei scientifici stanno vivendo una fase di rilancio grazie a proposte innovative, che promuovono la divulgazione scientifica e la consapevolezza ambientale con progetti specifici, evolvendosi da luoghi di conservazione a centri dinamici di apprendimento.
All’interno di questi i Musei di Chimica, al di là di cluster all’interno di temi museali più generali, quali salute, alimentazione, ambiente sono riferiti a Dipartimenti Universitari rappresentandone preziosi arricchimenti scientifici documentali e culturali
Elettronica commestibile.
Ha fatto recentemente parlare di se, anche in TV, un lavoro, pubblicato in realtà già un paio di anni fa e relativo alla costruzione di una batteria i cui componenti sono tutti alimenti, dunque una batteria commestibile.
Il lavoro lo trovate qui, ad opera di un gruppo milanese, presso Polimi-IIT diretto da Mario Caironi e descrive una batteria perfino ricaricabile, capace di poco meno di 0.7V.
Nell’abstract gli autori dichiarano:
La batteria è realizzata immobilizzando riboflavina e quercetina, ingredienti alimentari comuni e integratori alimentari, su carbone attivo, un additivo alimentare molto diffuso. La riboflavina è utilizzata come anodo, mentre la quercetina è utilizzata come catodo. Incapsulando gli elettrodi nella cera d’api, si ottiene una batteria completamente commestibile in grado di fornire energia a piccoli dispositivi elettronici. La cella della batteria di prova ha funzionato a 0,65 V, sostenendo una corrente di 48 μA per 12 minuti.

Riboflavina o vitamina B2, anodo

Quercetina, catodo
Ricordiamo che l’anodo in una batteria è il luogo delle ossidazioni ed il catodo quello delle riduzioni; i processi ossidoriduttivi implicati sono mostrati qui sotto; ricordiamo che l’aggiunta di elettroni o sottrazione di elettroni è rappresentata qui come accompagnata da un protone rispettivamente di modo che la riduzione è l’aggiunta di un atomo di idrogeno e l’ossidazione la perdita del medesimo atomo.
Gli atomi interessati sono i due azoti non derivatizzati nella riboflavina e i due ossigeni della quercetina sul secondo anello benzenico (si veda per una più ampia discussione sulle strutture qui).
All’anodo sarebbe:

E al catodo invece

Le due molecole interessate sono presenti comunemente con ruoli importanti negli esseri viventi.
L’idea di sviluppare dispositivi commestibili come generatori di energia elettrica, ma anche di sensori ed in genere di dispositivi elettronici commestibili è solo di qualche anno più antica e può certamente essere assegnata a Caironi; potete trovare una review sul tema dell’elettronica commestibile in questo lavoro recente che descrive anche alcune delle prospettive implicate nella ricerca.
Tuttavia le origini storiche risalgono almeno agli anni 50 ma in una forma un po’ diversa, ossia all’idea di R. Stuart Mackay e Bertil Jacobson chegià negli anni ’50, realizzarono le prime “endoradiosonde”, ossia piccole capsule ingeribili per monitorare parametri interni del corpo (dispositivi medici ingeribili per pH, temperatura e pressione), ponendo le basi per l’elettronica ingeribile medica. Dalla semplice ingeribilità si è passati con Caironi alla più complessa edibilità o commestibilità
Per parlare di elettronica occorre individuare molecole e materiali che siano non solo commestibili, ma che mostrino le caratteristiche basilari necessarie per la costruzione di dispositivi elettronici, dunque isolanti, conduttori e semiconduttori.
Nella illustrazione qui sotto si possono vedere alcuni degli elementi che si comportano nelle tre modalità:
da isolanti sono l’amido di mais, la chitina (ricavata dai gusci dei gamberetti), i broccoli essiccati, l’albume, il lattosio e la gommalacca;
gli elementi che fungono da conduttori sono l’oro commestibile, il carbone nero, il limone, la bevanda Gatorade e la Marmite;
gli elementi che fungono da semiconduttori sono le carote, il perilen di-immide (presente nei rossetti), la riboflavina (vitamina B2) e il colorante alimentare indaco carminio.

Anche se la base appare (ed è) ristretta, con questi materiali si possono azzardare le prime esperienze di elettrochimica ed elettronica a sfondo alimentare.
L’idea che sta dietro queste ricerche è di poter usare senza rischio dispositivi in grado di svolgere analisi anche complesse dall’interno di un corpo umano o animale:

Ma si può andare tranquillamente al di là, perché la possibilità di mescolare senza rischio sorgenti di energia e sensori al cibo consentirebbe di monitorare la situazione di un alimento in tutto il suo percorso, dalla produzione, alla conservazione al consumo, come si vede in questa immagine consentendo direttamente al consumatore di accertarsi della qualità dell’alimento. E questo si potrebbe fare sia per cibi prodotti da terzi che per quelli prodotti in casa, per esempio le famose conserve alimentari casalinghe che questa estate sono andate sotto accusa per il loro uso disinvolto, che può causare danni irreparabili.

Per il momento la cosa rimane una possibilità, ma si sono gettate le basi di un interessante progresso in questo settore.
A gloria della vaselina.
Claudio Della Volpe
Questo post ha una storia divertente; leggo un articolo sul presidente dell’Università di Trento* scritto da Travaglio sul Fatto quotidiano (https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2025/12/06/missili-con-vaselina/8218910/) e lo mando a qualche amico. È un racconto di come il nostro presidente supporti la guerra europea ed anche una fantasiosa visione della storia (tipo (senza prova alcuna) che la brexit sia stata voluta e spinta dalla Russia: “quando gli inglesi votarono la Brexit sotto influenza della Russia“), presentandola con un approccio che Travaglio definisce da vaselina (fra il gentile e l’untuoso), da cui il titolo. Ve lo consiglio, divertente (e tragica) lettura.
Uno degli amici mi risponde dopo un po’ chiedendomi se conosco la storia della vaselina e che secondo lui andrebbe bene sul blog. E allora mi attivo ed ecco qua il post.

La vaselina in quanto tale esiste ufficialmente dal 1872, anno in cui il chimico anglo-americano Robert Augustus Chesebrough la registrò come nome commerciale. In realtà l’aveva scoperta per caso nel 1859 visitando una piattaforma petrolifera in Pennsylvania.

Robert Augustus Chesebrough
Aveva iniziato la sua carriera come chimico per chiarificare l’olio di lampade da olio di spermaceti, un olio ceroso presente nelle teste dei capodogli. Lo sviluppo del petrolio da carbone e la scoperta del petrolio vero e proprio a Titusville, Pennsylvania, resero obsoleto il suo lavoro.
Si racconta che nel 1859 si recò a Titusville per studiare quali nuovi materiali potessero essere creati dal nuovo combustibile. Mentre passeggiava nel campo petrolifero, scoprì qualcosa chiamato rod wax, una sostanza gelatinosa che veniva spesso pulita dalle attrezzature di pompaggio. A Chesebrough fu detto che era un fastidio, tranne quando qualcuno aveva un taglio o una ustione, in quel caso avevano scoperto che se veniva strofinata su una ferita, il dolore si riduceva e la guarigione si faceva più rapida.
Chesebrough si mise a studiare la cosa in modo approfondito, la brevettò nel 1865 o meglio ne brevettò la distillazione e la sperimentò su stesso in molte applicazioni, mettendola in vendita poi nel 1872; il successo fu straordinario, ne vendeva migliaia di barattoli al giorno.
Accludo qui l’immagine relativa al brevetto, molto ben scritto e ricco di informazioni.

Chesebrough la commercializzò con il marchio Vaseline (o gelatina di petrolio). Questo nome probabilmente viene dalla fusione di due parole una tedesca ed una greca, il tedesco Wasser (acqua) e il greco elaion (olio), con il suffisso “-ine”. Il nome originale significava quindi “olio d’acqua” o “acqua oleosa”, descrivendo la proprietà macroscopica essenziale di questa miscela di idrocarburi derivata dal petrolio
La vaselina (Nome INCI: petrolato) chimicamente è una miscela semi-solida e purificata di idrocarburi saturi (alcani e cicloparaffine anche naftenici) derivata dalla raffinazione del petrolio, composta principalmente da catene di carbonio lunghe (