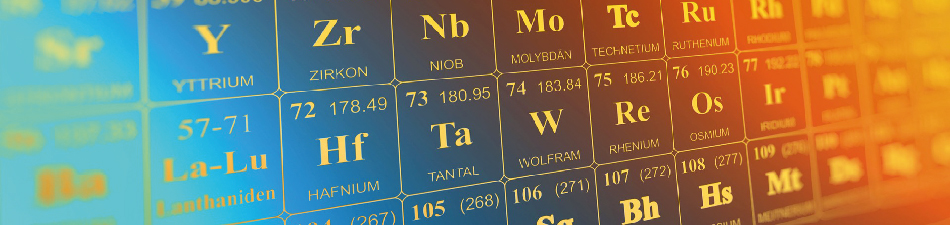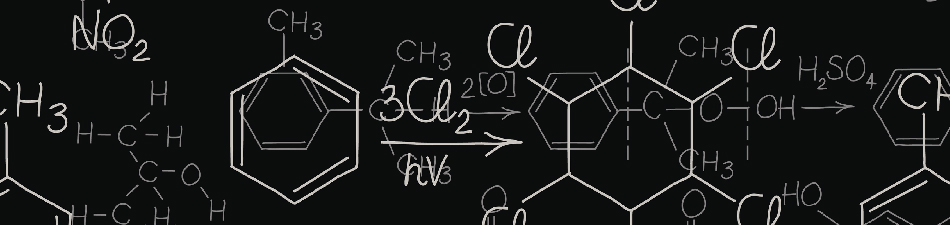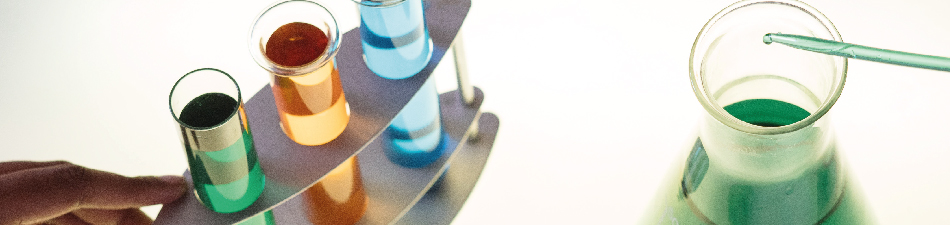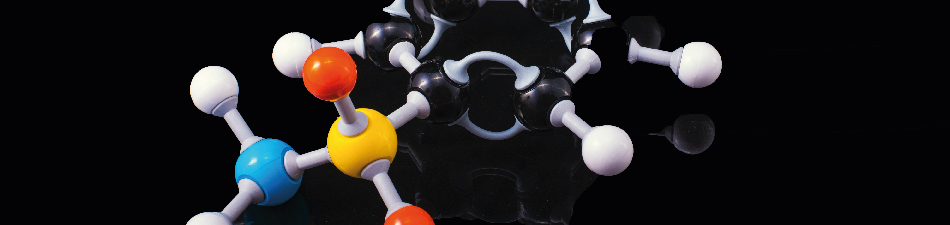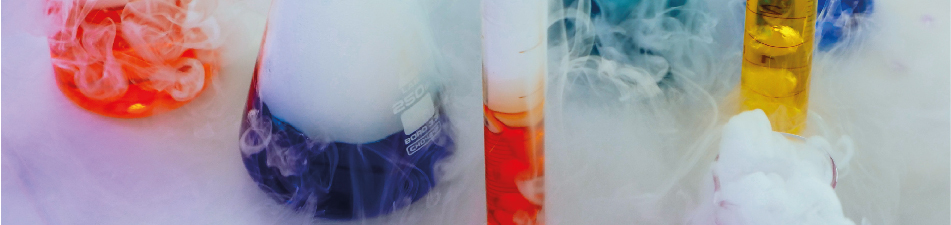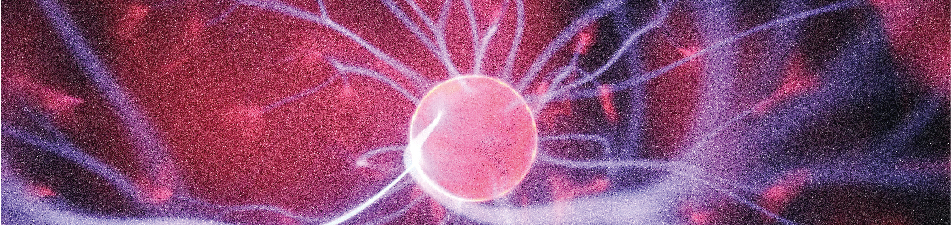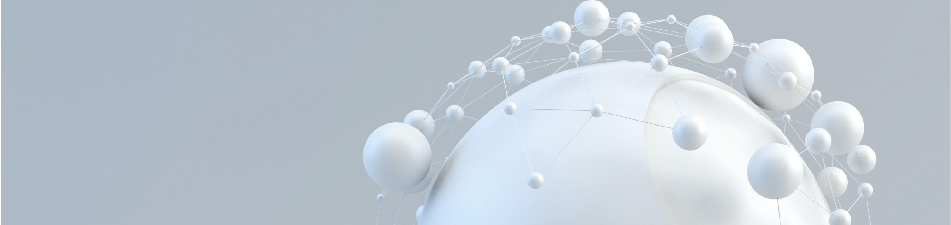Feed aggregator
Aggiornamento sul glifosato.
Claudio Della Volpe
A suo tempo (2015-2017 e poi 2022) seguimmo con ricchezza di particolari il conflitto fra le grandi istituzioni pubbliche mondiali, IARC, il braccio “armato” dell’OMS contro i tumori e l’EFSA, e l’ECHA le agenzie per la salute europea e per il controllo dei prodotti chimici, a proposito della classificazione del glifosato.
Se ricordate (ma potete andarvi a leggere i numerosi post che scrivemmo, elencati in fondo) il primo classificò il glifosato come un “probabile cancerogeno” cat. 2A, mentre l’EFSA e soprattutto l’ECHA invece lo approvarono ripetutamente come privo di rischi per l’uomo.
La differenza era molto importante ma comprensibile fino ad un certo punto, in quanto mentre lo IARC si occupa del pericolo tumori, l’EFSA valuta il rischio, il pericolo effettivo, in un caso specifico; il caso ECHA era più grave in quanto ECHA valuta anch’essa il pericolo, non il rischio; facemmo notare che la differenza veniva anche da altri fattori: IARC usa per le sue valutazioni solo esperti senza conflitti di interesse e solo lavori pubblicati su riviste di grande prestigio; tenete presente che ECHA usa invece tutta la letteratura e perfino report interni delle aziende produttrici; la stessa cosa avviene per EPA, l’equivalente americano. In molti casi i report interni NON sono pubblici, dunque è come se stessimo chiedendo all’oste se il vino è buono, non proprio in realtà, ci sono commissioni scelte ad hoc e dovrebbero essere imparziali ed attente, insomma la questione è complessa, MA, come abbiamo scritto molte volte il problema sta nei dettagli.
Ora perché ve ne riparlo?
Perché uno dei più citati lavori a favore del glifosato e che contraddiceva la posizione IARC è stato RITRATTATO.
Scrive van den Berg, che lavora all’Università di Utrecht. “Questo articolo è stato ampiamente considerato come un documento fondamentale nel dibattito sulla cancerogenicità del glifosato e del Roundup”, “Tuttavia, la mancanza di chiarezza su quali parti dell’articolo siano state scritte dai dipendenti della Monsanto crea incertezza sull’integrità delle conclusioni tratte”.
Il lavoro fa notare Science in un suo articolo di commento, è stato usato e criticato nei processi che sono in corso negli USA da parte di chi si ritiene danneggiato dall’uso del glifosato (linfoma non-Hodgkin) e in quei processi (che fra l’altro hanno obbligato le ditte produttrici a rendere pubblici altri report interni) è venuto fuori che i testi del lavoro erano stati, almeno parzialmente, scritti da Monsanto ma firmati dagli autori. Questo ne ha ovviamente inficiato il valore scientifico.
Insomma i dubbi posti già anni fa sul valore dei lavori pubblicati e sulle diverse procedure di IARC e ECHA sono stati rinforzati.
E’ un caso da manuale e dovrebbe farci pensare molto bene a questi problemi etici che sono fondamentali; se le persone comuni i non scienziati, ma anche parecchi scienziati, contestano alcune conclusioni della scienza la ragione sta nel peso relativo che il denaro e il profitto hanno nella produzione della scienza.
Dovremmo essere SEMPRE i primi a contestare le cose dubbie ad avanzare dubbi ed invece stentiamo a farlo; il caso PFAS sul quale, nonostante gli sforzi che occorre riconoscere dell’attuale presidenza, non siamo stati capaci di produrre un documento e men che meno unitario, è un esempio della nostra debolezza.
Non possiamo più chiederci perché molti credano che “chimico” sia una parolaccia, abbiamo sotto i nostri occhi il motivo. E lo abbiamo anche dentro di noi.

In Europa, il glifosato è stato rinnovato per altri 10 anni, fino a dicembre 2033, dopo che la Commissione Europea ha prorogato l’autorizzazione nel 2023 a causa della mancanza di una maggioranza qualificata di Stati membri, introducendo però restrizioni aggiuntive, come il divieto di uso pre-raccolta come essiccante e il divieto di coformulazioni con ammina di sego polietossilata. L’Italia ha restrizioni proprie, vietando l’uso in aree pubbliche e pre-raccolta, ma l’uso agricolo è consentito con limiti quantitativi e specifici per colture, specialmente quelle in regime di difesa integrata o biologica. In particolare l’Italia ha già vietato l’uso di prodotti a base di glifosato in aree verdi pubbliche (parchi, giardini, ecc.) e nelle fasi di pre-raccolta (essiccamento). È vietato l’uso di diserbanti chimici per le colture leguminose e foraggerementre per le colture da rinnovo (es. grano duro) l’uso è permesso in regime di difesa integrata o biologica, rispettando i limiti previsti dalle etichette e dai disciplinari e sono stati introdotti limiti massimi di utilizzo con possibilità di superamento (fino al 70% della SAU) per aziende che aderiscono a specifici impegni agroambientali.
Termino con l’aggiornamento della questione resistenze agli erbicidi, che pure trovate nei vari post.
Attualmente ci sono 539 casi unici (specie x sito d’azione) di erbacce resistenti agli erbicidi a livello globale, con 273 specie (156 dicotiledoni e 117 monocotiledone). Le erbacce hanno sviluppato resistenza a 21 dei 31 siti di azione per erbicidi noti e a 168 diversi erbicidi. Infestanti resistenti agli erbicidi sono state segnalate in 102 colture in 75 paesi. Il caso del glifosato è mostrato nel grafico seguente.

Non si può fare un deserto e chiamarlo agricoltura intensiva; dobbiamo trovare un modo più rispettoso di fare agricoltura ed allevamento; e noi chimici non dovremmo essere complici di queste situazioni e denunciarle appena si evidenziano, altrimenti non potremo manco protestare quando Sabrina Giannini (la giornalista, che non mi sta molto simpatica, di “Indovina chi viene a cena”) si scaglia contro “la Chimica”, manco fossimo tutti untori; scriverò qualcosa sulla Giannini, ma finché non saremo capaci di fare da guardie della natura non me la sento di darle tutti i torti. Se non lo facciamo noi si troverà qualcun altro, sicuramente meno qualificato, che lo farà al posto nostro.
Storia aggiornata della retrazione: https://retractionwatch.com/2025/12/04/glyphosate-safety-article-retracted-elsevier-monsanto-ghostwriting/
Lista dei post pubblicati sul glifosato
A volte ritornano. La battaglia del glifosato. Glifosato e api da miele Glifosato. Dove siamo? Parte 2. Altri fatti e qualche opinione. Glifosato: dove siamo? Parte prima: alcuni fatti. Ma insomma il glifosato è o non è cancerogeno? Non c’è due senza tre: ancora glifosato.(parte 1) Ancora sul glifosato. Glifosato e altre storie Agricoltura sostenibile.La frutta “sporca” e la struttura degli esseri viventi
Claudio Della Volpe
Quante volte avete pensato che i mirtilli o l’uva o le prugne che stavate mangiando avessero bisogno di una buona lavata a causa di quella pellicola bianca che sembrava proprio “sporco”.
Ma era sporco?
No! Non proprio. Era un film protettivo dotato di complesse proprietà e di una specifica composizione di cui discuteremo brevemente oggi. Un po’ di sporco c’è, ma vedremo meglio nel testo.
E c’è una sorpresa, questo tipo di patine è presente non solo su molti frutti, ma anche su molti insetti. Il nome inglese di questo tipo di film è pruinescence; in italiano la chiamiamo pruina o pruinosità.
La pruina è una sottile patina cerosa e biancastra che ricopre la buccia di molti frutti e foglie, come l’uva, i mirtilli, le prugne e le foglie delle piante grasse e anche in alcuni casi i funghi.
Svolge una funzione protettiva naturale contro raggi UV, disidratazione, parassiti e batteri. Inoltre, sulla superficie dell’uva, aiuta a trattenere i lieviti indigeni necessari per la fermentazione, dunque è importante per la produzione del vino; oggi si capisce che la sua presenza e il suo mantenimento contribuiscono ad ottenere un vino di caratteristiche organolettiche specifiche. Qui ci sarebbe da fare un discorso complesso perché di fatto una pulitura della buccia dell’uva ha senso anche ai fini della successiva produzione di vino, ma sarebbe necessario un apposito post per illustrare il problema; chi è interessato può consultare il bel lavoro linkato in fondo scritto dai colleghi dell’Istituto Mach di San Michele all’Adige, nel quale si illustra la procedura di pulizia ed i risultati.
La composizione della pruina è specifica dell’essere vivente su cui essa si sviluppa; tuttavia è possibile trovare alcune molecole che sono presenti più comunemente.



Chi come me ha studiato per trent’anni la bagnabilità trova molto stimolante che l’antesignano di un’idea di stratificazione corporea basata sulle proprietà di “bagnabilità” (secco fuori, umido dentro) sia il sistema filosofico-medico di Aristotele e Galeno, che concettualizzavano queste differenze in termini di qualità primarie (secco/umido) applicate all’intero organismo come sistema olistico, molto prima che si comprendesse la biologia cellulare moderna.
Oggi si sa che sia le piante che gli animali presentano spesso dei gradienti di bagnabilità in genere con una faccia o una cuticola più idrofobica all’esterno ed una maggiore idrofilicità interna, ma con grandi specificità.
Un caso di questi lo abbiamo accennato in un precedente post, sulla presenza di idrocarburi in alcuni tipi di cavolo.
Tornando al caso dei frutti che dicevamo all’ìnizio, le cuticole cerose vegetali (epicuticular wax in inglese) hanno una struttura complessa che si vede qui sotto al microscopio elettronico; nella struttura rimangono intrappolati anche elementi ambientali di vario genere dagli inquinanti ai fermenti.

Postharvest Biology and Technology 173 (2021) 111430
Nelle cuticole vegetali presenti si trovano vari composti come acido oleanolico, stigmasterolo, alcoli, esteri e aldeidi.


Acido oleanolico (sopra) e stigmasterolo (sotto)
Proprio per questo è possibile estrarle facilmente immergendo il frutto in un solvente scelto appositamente ed in cui le cere si sciolgono completamente rilasciando anche il contenuto estraneo eventualmente adsorbito.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925521422003234
Gli scopi della pruinescenza sono comuni a molte piante e frutti: proteggere il frutto dall’acqua, che trasporta agenti biologici negativi come le muffe per esempio, oppure ridurre l’impatto dei raggi UV.

La patina di pruina su queste foglie di Echeveria per esempio serve a difendere la pianta dai raggi UV e toccare le foglie le danneggia.
Stessa situazione su questa Russula

Insomma la patina bianca che si trova su certi frutti o piante può essere del tutto naturale e, se del caso, possiamo mangiarla senza timore: non è giusto considerarla sporco, anzi fa parte integrante del frutto stesso, (ATTENZIONE) anche se può contenere impurità ambientali. Un consiglio pratico è di pulire la frutta quando è il caso con un panno o un foglio di carta invece che lavarla.
Completamente diversa la patina NERA che si può trovare in alcuni casi, la fumaggine, che invece è il segno di un attacco fungino in corso.

La pruina sugli insetti merita un discorso a parte che non faremo oggi; è anch’essa un rivestimento ceroso, polveroso che conferisce loro un aspetto smerigliato, comunemente bianco, azzurro pallido o grigio. Questo rivestimento è generato da particelle di cera sulla cuticola dell’insetto che diffondono la luce e può avere diverse funzioni, anche più complesse di quelle delle piante, tra cui il riconoscimento della specie e del sesso, la difesa del territorio e la termoregolazione per raffreddare il corpo. Ne parleremo un’altra volta.
Ringrazio Fulvio Mattivi del FEM di San Michele all’Adige per gli utilissimi suggerimenti.
Testi per approfondire:
articolo scritto dai colleghi della Fondazione Mach di san Michele all’Adige sul tema della pulizia delle uve e dell’analisi della loro pruina; si vede che la pulizia addirittura favorisce la successiva fermentazione oltre a ridurre molto il possibile carico inquinante.
un filmato sull’uva trentina senza trattamenti e sulla pulizia dell’uva, molto istruttivo direi.